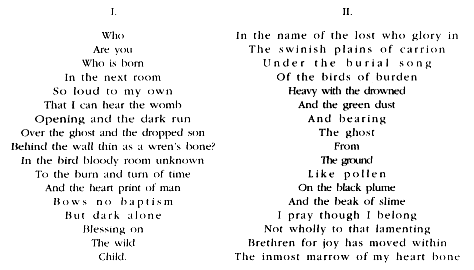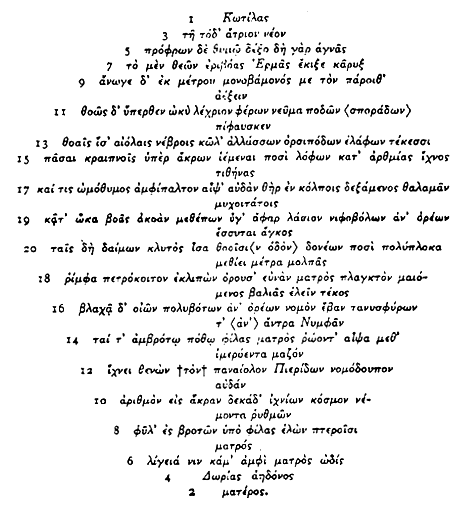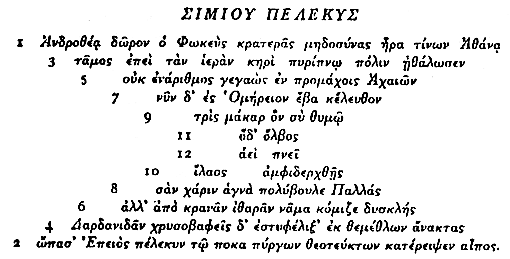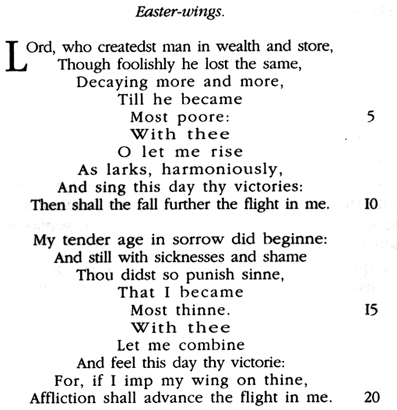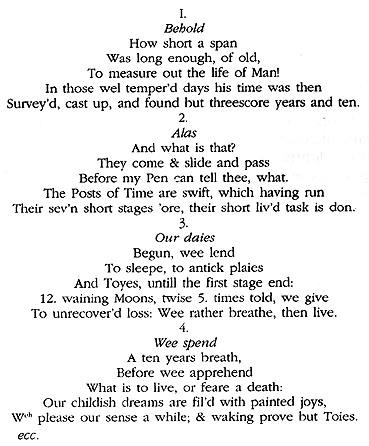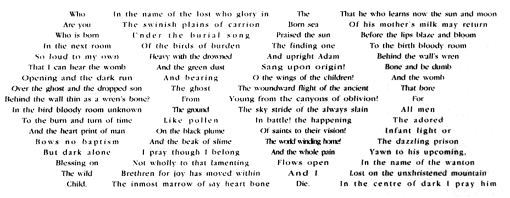Appunti e materiali per una lettura di Vision and prayer di Dylan Thomas di Roberto Sanesi - 1. La poesia Vision and Prayer fu inviata all'amico Vernon Watkins con una lettera da New Quay, Cardiganshire, datata 28 ottobre 1944. In una lettera del 15 novembre 1944, in risposta alle osservazioni di Watkins, Thomas commenta:
- Sono molto contento che Vision and Prayer ti sia piaciuta, e che la forma a diamante in cui è disposta la prima parte non ti sembri più costretta e artificiosa. Sono d'accordo con te che la seconda parte, dal punto di vista formale, è meno ineluttabile, ma non posso cambiarla, tranne, forse, in qualche dettaglio. Leggerò di nuovo l'ultimo verso, e vedrò che cosa è possibile fare riguardo agli accenti. Non ho qui una copia del poemetto ma, per quel che ricordo, l'ultimo verso mi piaceva proprio per gli accenti strani, per il frenarsi, per il rallentare degli ultimi due uccelli (ho scritto "uccelli" invece di "parole", delle ultime due parole aventi uguali vocali). Ma leggerò di nuovo il tutto, con grande attenzione. Sì, il Cane del Cielo abbaia nell'ultima stanza, ma, per il momento, e ancora una volta basandomi sulla memoria, non ricordo di aver visto niente di Hopkins dopo aver terminato il poemetto.
- (cfr. D.Thomas, Letters to Vernon Watkins, London, J.M.Dent and Faber & Faber, 1957, trad. italiana di Ariodante Marianni, Lettere a Vernon Watkins, Milano, Il Saggiatore, 1968).
- Si noti che Thomas, nel dire "formale", intende in senso strutturale ritmico linguistico, non in senso di figurazione visibile, a cui tuttavia il poemetto risponde. E questo anche nel caso, evidentemente, dell'immagine "diamante" se è a questo proposito che si evoca Hopkins, per quanto non sia chiaro perché avrebbe dovuto "vedere" qualcosa dopo aver terminato il poemetto. Prima, Hopkins sembra essere stato ampiamente letto da Thomas, (cfr. Swansea Grammar School Magazine, vol.26, n.3 , dicembre 1929, riportato in R. Sanesi, Dylan Thomas, Milano, Lerici, 1960), sebbene il poeta si mostri sempre piuttosto reticente ad ammetterne l'influenza.
- 2. Poesia come fenomeno, Vision and Prayer (prima pubblicazione in Horizon, XI, 61, Gennaio 1945) si dispiega, e si spiega, "progressivamente", per figure di spostamento e differenza.
- La prima sezione della poesia si compone di sei forme a "diamante", la seconda di sei forme a "clessidra", una per pagina: