- Un giorno l'Uomo del destino / trovandosi
invitato ad un festino / gonfiò il petto
meglio di un tacchino / e salutò il Poeta
tra i presenti: "Al più grande di tutti
io mi inchino". / "è pur vero" rispose
quello sull'attenti / "non è da tutti
misurar due metri".
- Episodio vero e riportato da varie fonti.
L'uomo del destino (è fin troppo noto di
quale destino), c'è da dirlo?, altri non
era che Mussolini. Il Poeta, il gigante le cui
titaniche proporzioni erano come corrette e
smussate dall'espressione fanciullesca, si
chiamava invece Carlo Alberto Salustri, in arte
Trilussa. Di aneddoti come questi - che sembrano
stiano lì a compensare la vistosa assenza
di azioni, dichiarazioni, prese di posizioni
plateali del genere tanto caro a un caro amico
di Trilussa, il "parlante animale", come a lui
stesso capitò di definirsi, Gabriele
D'Annunzio - la biografia trilussiana è
ricchissima. Né potrebbe essere
altrimenti: nato nel 1871 e morto nel 1950 - e
dunque quest'anno si celebrano i cinquant'anni
dalla morte - vissuto sempre a Roma senza
disdegnare piacevoli soggiorni in varie
città italiane e straniere, gran
frequentatore e animatore di salotti e teatri
come di osterie, caffè e varietà,
"tombeur de femme" al pari - questa volta
sì - del collega D'Annunzio, col quale
anzi amava passeggiare, entrambi al braccio di
qualche bella signora, per i viali di Roma,
Trilussa ha attraversato ottant'anni di storia
italiana con la leggerezza dell'ape cantata in
una delle sue ultime poesie. "C'è un'Ape
che se posa / su un bottone de rosa / lo succhia
e se ne va/ Tutto sommato, la felicità /
è una piccola cosa". Un'ape che,
peraltro, non mancava di pungere con una sua
speciale grazia irriverente, né di
ronzare nei posti più impensati
raccogliendo i segreti più intimi,
sorridendone tra sé prima ancora di far
sorridere altri.
- Perché divertire il prossimo era
ciò che Trilussa sapeva fare meglio, e la
gente gli voleva bene per questo. Che gente? Ma
il popolo: quello di Roma, prima di ogni altro,
quel popolo che mandava a memoria le sue poesie,
le recitava per la strada, le cercava sulle
riviste per poi declamarle insieme agli amici o
in famiglia. Il popolo che lo salutava per la
strada, gli offriva un bicchiere di Frascati, lo
additava quando entrava o usciva dallo
studio-abitazione felicemente descritto da
Silvio d'Amico in una famosa pagina: "un grande
studio da pittore, presso il Lungotevere Arnaldo
da Brescia, tappezzato e ammorbidito; una sorta
di compromesso fra l'estetismo della Capponcina
dannunziana e la dimora bohémienne, con
tappeti e divani e quadri e disegni e animali
imbalsamati e arredi ecclesiastici e lampade
misteriose e libri ben legati e statuette e
strumenti musicali e, soprattutto, una
quantità di fotografie e un subisso di
caricature". Quello stesso popolo di portinai,
servette, camerieri, facchini, maghi e sartine
che animava i dialoghi dei suoi versi con
l'arguzia, il cinismo e la prontezza che si
usano riconoscere nella gente comune, e forse a
Roma più che altrove.
- La popolarità di Trilussa - un
caldo affetto che lo circondò fin dai
suoi esordi per non abbandonarlo più -
non gli giovò quanto a fortuna critica.
Il favore del popolo, in Italia, è sempre
stato guardato con sospetto e aggrottar di
ciglia dai notabili della letteratura: se piace
tanto ci deve essere qualcosa che non va.
Proviamo a riformulare il ragionamento: il
popolo ha gusti popolari - per la gioia di
Monsieur de Lapalisse - perché non
è educato, non è raffinato, non
è attento, non ha spirito critico. Quindi
non ha un buon metro di giudizio. Altri devono
essere gli strumenti: l'attenta
sensibilità del cultore della materia, la
sua preparazione a cogliere la precisione del
metro, l'innovazione, l'originalità, le
architetture della sintassi. Detto così
non fa una piega. Ma allora, e questa è
la domanda che ci tormenta, perché la
poesia è nata in mezzo al popolo e al
popolo veniva cantata dagli aedi (e quella
poesia adesso è posta per concorde
giudizio critico sulla vetta delle umane
espressioni artistiche), perché era il
popolo di Atene, per non parlare di quello
londinese di qualche secolo dopo, a decretare la
fortuna o la sfortuna di tanto teatro e nessuno
si sognava di mettere in discussione il suo
giudizio (e quel teatro viene ancora oggi
riproposto con la benedizione della critica),
perché la Commedia (quella Divina) veniva
cantata nei vicoli dai fabbri intenti a
martellare spade, perché I promessi sposi
e I miserabili divennero sin dalla prima uscita
popolarissimi? Sarà che il popolo,
talvolta, ha l'occhio lungo almeno quanto i
critici? Vien da pensare, piuttosto, che
esistano autori i quali hanno orecchie per
ascoltare ciò che il popolo dice nelle
strade e nelle piazze, e cuore abbastanza per
riproporlo togliendogli l'inevitabile patina di
banalità e quotidianità per
donargli ali più ampie e respiro
universale. E questi autori il popolo li scova
immediatamente, li vuole, li reclama, li legge e
li rilegge, li coccola. Perché parlano di
cose semplici - che ad altre e più
raffinate orecchie possono anche offrire squarci
di profondità e altezze vertiginose -
come l'acqua e il vino: titolo, non a caso, di
una raccolta di Trilussa.
- Se invece vogliamo fare un discorso di
domanda-offerta editoriale, allora la questione
si complica. Perché se la storia ci
mostra che il popolo ha denti buoni anche per
masticare buona letteratura, purché
gliela si offra, ci insegna allo stesso modo che
il popolo può masticare qualsiasi cosa,
para-letteratura, o addirittura letteratura
cattiva (ma avrà senso parlare di cattiva
letteratura? Chi decide in proposito? Ecco un
altro dubbio che ci tormenta). Dipende sempre da
quel che trova in giro. Considerazione cui ne
seguono a ruota molte altre: che vanno dalla
riflessione, tipicamente nostrana, sulla
schizofrenia scrittori-popolo (schizofrenia le
cui radici salgono su su fino a Petrarca) alla
constatazione, che invece non ha sede fissa
perché dimora ovunque ma soprattutto qui
e ora, che la logica del profitto non è
propriamente buona consigliera in fatto di
scelte editoriali.
- Trilussa, dicevamo, sconta agli occhi di
molti critici il peccato originale di un vasto
successo di pubblico, che peraltro non accenna a
diminuire: il dato più recente che
abbiamo trovato dice che nel 1977 l'edizione
mondadoriana di Tutte le poesie aveva toccato
quota 26a ristampa. Dato che, per la poesia
italiana, ha del miracoloso. Ciò che
constatava tra lo stupefatto e l'ammirato anche
Silvio d'Amico, il primo a dedicare a Trilussa,
nel 1943, uno studio critico di un certo
spessore: "che diremo di Trilussa, unico fra i
poeti della Letteratura italiana dalle origini
ai nostri giorni, il quale abbia goduto e goda
d'un tal pubblico di lettori, da poter
materialmente vivere del frutto de' suoi versi?
Non si dice prosa, non si dice teatro: si dice
versi". Abbiamo già cercato di
individuare il motivo di tanto straordinario
successo: contenuti semplici, motti arguti, quel
tanto di saggezza che ciascuno sente di portare
anche nelle proprie tasche con in più un
costante atteggiamento di irriverenza, ma non di
scherno, di smitizzazione, ma non di
aridità; e poi la lingua: un romanesco
facile, orecchiabile, comprensibile anche a chi
romano non è. La lingua parlata nella
Roma neo capitale d'Italia, dove erano
già arrivati in massa funzionari da
Torino e da Firenze, mescolando i loro al
dialetto locale.
- È questo lo scenario in cui si
muove Trilussa: una città che è
appena diventata capitale e si avvia a diventare
il centro burocratico e amministrativo, ma non
industriale, d'Italia; tra i cui abitanti,
quindi, si conta il più alto numero di
piccoli impiegati, segretari, portaborse,
portinai, facchini, camerieri: tutta la
variegata fauna che si muove nei pressi e
intorno ai palazzi del governo. Lassù,
nelle stanze del potere, si inaugurava la
stagione sempreverde del trasformismo;
quaggiù si diffondeva la mentalità
piccolo borghese. Questa mentalità
Trilussa aveva respirato fin da bambino. Figlio
di un cameriere e di una sarta, nipote di un
prete, figlioccio del marchese De' Cinque
Quintili che, dopo la precoce morte del padre,
ospitò la famiglia nel suo palazzo (sono
ammesse perplessità sulla reale
paternità del nostro, ma avvertiamo
subito: nulla di certo ha potuto intaccare la
reputazione di Carlotta, la madre a dir poco
venerata), il poeta riassumeva persino nel nome
il desiderio paterno di non dispiacere a
nessuno: Carlo Alberto in onore alla monarchia,
Camillo per compiacere lo stato, Mariano in
omaggio alla religione. Non è chi non
veda, in ciò, una costante della piccola
borghesia: i poteri costituiti meglio tenerseli
buoni tutti, non si sa mai. Dal quinto piano di
palazzo De' Cinque il giovane Carlo Alberto, non
ancora Trilussa, osservava la folla di dame e
damerini nella via sottostante, ascoltava le
confidenze delle signore della buona borghesia
che frequentavano la sartoria materna, alzava
gli occhi e fissava la biancheria stesa ad
asciugare, e più in là i tetti e
le mansarde fiorite, e oltre ancora i colori del
cielo. Ascoltava, forse, i sospiri della madre
che ricordava la figlia morta a tre anni, appena
uno dopo la nascita del maschietto, e
sicuramente le sue raccomandazioni a studiare,
prima, e a non fare tardi, dopo. Vane entrambe:
dopo aver frequentato senza grandi risultati due
collegi, nel 1888 il giovanotto abbandona gli
studi regolari (mai e poi mai, si disse,
diventerò contabile, e al diavolo i
consigli dello zio prete); poco dopo comincia a
pubblicare sonetti su riviste locali e
già nella prima metà degli anni
Novanta è redattore del Don Chisciotte.
Da allora, non smette più di scrivere i
sonetti e le favole per cui è acclamato
prima a Roma, poi in Italia, poi in Europa e
infine anche in Argentina, dove nel 1924 riceve
un'accoglienza trionfale. Ciò nonostante
la preoccupazione per il bilancio familiare,
vero chiodo fisso della piccola borghesia
risparmiatrice, non lo abbandonò mai:
quando venne nominato senatore a vita per
altissimi meriti nel campo della letteratura,
venti giorni prima di morire, il suo primo
commento rivolto alla fedele governante Rosa fu:
"semo ricchi".
- Trilussa dava voce al sentimento e alla
mentalità piccolo borghese perché
tale era egli stesso; la sua satira non
risparmiava nessuno perché era lui per
primo a non risparmiarsi: "da allora in poi
nasconno li dolori / de dietro a un'allegria de
cartapista / e passo per un celebre egoista /
che se ne frega de l'umanità". Mascherare
le proprie emozioni (La maschera è il
titolo della poesia da cui sono tratti i versi
appena citati), nascondere una lacrima tra le
risate, togliere il velo ai buoni sentimenti e
alle ideologie di tutti i colori, rivoltare i
buoni propositi per scoprire che "fratellanza"
fa sempre rima con "panza": questo faceva
Trilussa con i suoi versi e le sue favole.
Aristocratici, intellettuali, politici, preti,
gente del popolo: come s'è detto ce n'era
per tutti. Durante una campagna elettorale i
socialdemocratici affissero sui muri di tutta
Roma i versi de La cornacchia liberale, una
poesia che finisce così: "Oggi che la
coscenza nazzionale / s'adatta a le finzioni de
la vita / Oggi ch'er prete è mezzo
libberale / e er libberale è mezzo
gesuita / se resti mezza bianca e mezza nera /
vedrai che t'assicuri la carriera"; detto fatto,
un'ora dopo i liberali rispondevano con un'altra
affissione, quella de Er compagno scompagno: "-
No, no: - rispose er Gatto senza core - / io non
divido gnente co' nessuno: / Fo er socialista
quanno sto a diggiuno / ma quanno magno so'
conservatore!". Se il senno di poi ce lo
consentisse, si potrebbe giudicarli versi
intessuti di malafede e di cinismo. Ma, ahinoi,
non possiamo riconoscervi che una verità,
per quanto spicciola, sinora mai smentita: la
coerenza non fa parte, in genere, del corredo
cromosomico degli uomini politici. A elezioni
finite, chi fosse il vincitore poco importa,
ecco Er ministro novo: "Mò va gonfio,
impettito, a panza avanti: / nun pare
più, dar modo che cammina / ch'ha dovuto
inchinasse a tanti e tanti / Inchini e inchini:
ha fatto sempre un'arte! / Che novità
sarà pe' quela schina / de sentisse
piegà dall'antra parte!". Il vetriolo di
Trilussa corrode anche i paramenti sacri: "Don
Pietro, er presidente, fa la storia / de come
vanno l'organizzazione; / dice: - Co' li
tranvieri va benone, / co' li scopini è
stata una vittoria. - / Poi parla de le cariche
sociali, de l'elettori, de l'affari sui, / e de
banche e de sconti e de cambiali. / De tutto
parla meno che d'Iddio, / e forse er Cristo
penserà fra lui / - Se so' scordati che
ce so' pur'io!-".
- Il mondo di Trilussa è un
mondaccio, la gente "gentaglia e gentarella":
gli uomini sono ipocriti come quel bottegaio che
un momento prima era decisissimo a chiamare la
polizia e un momento dopo è tutto inchini
e sorrisi per il cliente che gli ha saldato il
debito; hanno la memoria corta come
quell'innamorato che dopo qualche tempo
risponde, a chi gli domanda della donna del
cuore, "e chi si ricorda più"; le donne
sono false come quell'unica cantante di
caffè concerto che non mette la veste
corta non per onestà, ma per non mostrare
le gambe storte; vanitose come quella nonna che,
a ripensare alla pietra preziosa offerta da un
amante rifiutato in gioventù, ancora si
morsica i gomiti. L'amore? è la testa del
satiro nascosto in mezzo alla mortella a Villa
Medici: "Pareva quasi che ner vede a noi /
ridesse e borbottasse fra de lui: / - N'ho visti
tanti e tanti come voi / innamorati fracichi, ma
poi / ognuno è annato pe' li fatti
sui!-". Un mondaccio che vive tutto intero nei
sonetti, genere prediletto dal grande Belli e
ripreso con somma perizia tecnica da Trilussa:
è ancora d'Amico a riconoscergli "la
facoltà di concepire in sonetti, di
ridurre il mondo e la vita a sonetti, di
padroneggiare la quadrata e stupenda forma del
sonetto come cosa propria, e farne un mezzo
d'espressione assoluto e perfetto. Chi, dopo il
Belli, ha saputo come Trilussa adattar
così spesso entro la ferrea cornice del
sonetto quadri tutti essenziali, senza
superfluità né ritagli né
sforature, con quei versi precisi e cadenzati
nei quali la frase combacia nativamente e
logicamente con la misura dell'endecasillabo?".
Abilità di compositore che gli hanno
riconosciuto anche altri: da Renato Serra,
finissimo cultore e intenditore di poesia che
nel 1913 scriveva: "Trilussa ha anche una
bravura e un sapore di verseggiatura che sfugge
di solito nel gioco dei motti a cui il pubblico
bada; ma è qualità d'artista" a
Borgese, autore nel 1909 di una vera e propria
stroncatura nella quale tuttavia ammetteva,
quasi a denti stretti, che "Trilussa è
artista di piccola ma sicura forza". La stessa
"bravura di verseggiatura" si ritrova nelle
favole, che sono però concepite in forme
più libere rispetto al sonetto dal
momento che metri e strofe diversi si mescolano
tra loro; cambiano anche i personaggi, che non
sono più uomini ma animali, ma la
sostanza rimane la medesima.
- Dissacrare, smontare, smascherare.
Trilussa prende spunto dalle favole di La
Fontaine per rovesciarne il finale riportandolo
alla sua ben nota morale. Così La cecala
d'oggi canta tutta l'estate incurante dei saggi
consigli della formica e quando arriva l'inverno
confida all'amica: "mò ciò
l'amante: me mantiè quer Grillo / che
'sto giugno me stava sempre appresso. / Che
dichi? L'onestà? Quanto sei cicia! /
M'aricordo mi' nonna che diceva: / Chi lavora
cià appena una camicia, / e sai chi ce
n'ha due? Chi se la leva"; la ranocchia, dal
canto suo, memore di quella antica progenitrice
che a furia di gonfiare il petto era scoppiata,
riflette: "Nun è possibbile ch'io possa /
diventà come lui [il bove]: ma
che me frega? / A me m'abbasta d'esse la
più grossa / fra tutte le ranocchie de la
Lega". Dopo aver riveduto e corretto le favole
della tradizione Trilussa si slanciò
nell'invenzione originale con una vera parata di
fuochi d'artificio: polli, oche, somari e
cavalli, piccioni e aquile, sorci e gatti,
leoni, pecore e maiali, tutti intenti a
disquisire, a sentenziare, a litigare nel comune
segno del tornaconto, della "panza". Tutti
portatori di una filosofia che potremmo chiamare
della Maria Tegami, il fortunato personaggio
scaturito dall'inesauribile fantasia trilussiana
che sulle colonne del Travaso commentava fatti
della cronaca e della politica con
"velleità letterarie inversamente
proporzionali alla mancanza di cultura"; tale fu
il successo degli articoli che l'editore li
raccolse in un volumetto, da regalare ai
lettori, che si apriva con una Autobiografia
dell'autrice: "A sette anni - scriveva Maria
Tegami - Trilussa - venne un signore
dall'America col barbone vestito di nero che era
mio padre. Fui messa in collegio a S. Dionisio
dove ci sono rimasta fino a diciotto anni. Mia
madre mi veniva a trovare un giorno sì e
uno no, con uno grasso e calvo, che era pure mio
padre. Molte volte baciavo quell'uomo dalle
gratelle del parlatorio avanti alla superiora e
mi pareva che nell'amplesso superficiale lui non
fosse paterno come si deve. [ ] Io pure
comprendevo che l'affare non era liscio e un
giorno che lui venne solo ci dissi a bruciapelo:
Ma è proprio vero che tu sei mio padre?
Lui, che si vedeva davanti una bambina che ci
faceva un discorso così serio,
diventò rosso, tossì e mi rispose:
No, bambina. Io sono un perito
agrimensore".
- Smascherare, smontare, dissacrare. Il
lavoro di Trilussa non era, in fondo, diverso da
quello che contemporaneamente stavano facendo
altri artisti in teatro. E il teatro, per
Trilussa, era una vera passione, variamente
dimostrata sia dall'attenzione che il poeta
riservava alle illustrazioni (piccole caricature
che sono vere e proprie "messe in scena" dei
suoi versi), sia dalla composizione di
macchiette per il teatro (per Maldacea e
Petrolini, ad esempio; di Trilussa era anche il
monologo La vispa Teresa che, recitato da Dina
Galli, ebbe enorme successo in tutta Italia),
sia dalla stessa composizione dei versi che
spesso hanno la forma di un dialogo che non
è difficile immaginare recitato sulla
scena. Nel 1927, poi, probabilmente stufo della
pesante cappa di conformismo imposta dal regime
fascista, Trilussa costruì con un amico
la "Baracca delle favole", un teatro di
burattini di cui egli tirava i fili e per cui
inventava gli scenari più stravaganti. E
a questo punto come non ricordare che uno dei
pochi successi scolastici del piccolo Carlo
Alberto Salustri fu una composizione che aveva
per tema "lo spettacolo della strada", nella
quale il bambino paragonava le marionette ai
candidati alle elezioni, constatando che in un
caso come nell'altro c'è sempre un
burattinaio che muovendo i fili tiene desta
l'attenzione del pubblico? Non deve sorprendere,
quindi, che l'interesse per l'immagine,
così vivo in Trilussa, lo conducesse al
cinema: lì, immaginava, c'era il futuro
dell'immagine e della comunicazione. Nel 1914
scrisse una sceneggiatura per un film,
ovviamente di grande successo, e nello stesso
periodo intratteneva cordiali rapporti con
Antonio Lumière, che lo invitò a
fare un viaggio a Napoli. Dall'immagine al
suono, per chi ha l'occhio lungo come l'aveva
all'epoca Trilussa, il passo è presto
fatto: ciò nonostante sorprende la sua
passione per gli strumenti della musica
popolare, proprio quella che, oggi chiamata
"etnica", suscita l'entusiasmo di tanti
intellettuali. Così come estremamente
moderne suonano certe sue dichiarazioni sulla
necessità, per l'uomo, di non
rinchiudersi dentro i confini di una sola
attività e, per lo scrittore, di non
considerare mai l'arte un mestiere. Come le api,
appunto, volava di fiore in fiore, e tra le sue
frequentazioni troviamo Marconi, Mascagni,
D'Annunzio, Mondadori, d'Amico,
Leoncavallo.
- Proprio il già citato d'Amico, per
primo, sottolineò le affinità che
parevano legare alcune trovate trilussiane e
certi lavori teatrali, ricordando in particolare
Morte degli Amanti, di Luigi Chiarelli, Danza su
di un piede di Rosso di S. Secondo e Quando si
è qualcuno di Pirandello; a queste se ne
potrebbe aggiungere una venuta parecchio tempo
dopo, La grande magia di Eduardo, nella quale la
trovata della moglie in scatola (che il marito
crede di tenere lì custodita per non
doverne ammettere il tradimento) sembra in
qualche modo richiamare L'illusione trilussiana:
"Er vecchio dava segni de pazzia. / Me disse: -
In quela scatola de latta / ciò chiusa
drento l'anima ch'ho fatta / pe' la biondina
ch'è scappata via".
- E ancora smontare, smascherare,
dissacrare. Niente sembra abbastanza sacro per
Trilussa. Salvo l'idea della divinità:
per quanto si accanisse contro i preti, nulla
nei versi di Trilussa appare gratuito, volgare e
offensivo nei confronti di Dio. La Fede di
Trilussa è qualcosa di semplice e
complicato al tempo stesso: "Credo in Dio Padre
Onnipotente, Ma / - Ciai quarche dubbio?
Tiettelo per te. / La Fede è bella senza
li 'chissà', / senza li 'come' e senza li
'perché'".
- Sono versi come questi che hanno guidato
alcuni critici, non molti per la verità,
alla riscoperta di un Trilussa un po' diverso da
quello, ben più noto, le cui cifre
restano il sarcasmo e la morale piccolo
borghese. Molte poesie nascevano dalla cronaca,
addirittura per la strada (come raccontava lo
stesso poeta. Ma non le scrivi subito? gli
domandavano. Non hai paura di dimenticarle?
Quelle che dimentico non meritavano di essere
ricordate, era la lapidaria risposta) e i
riferimenti all'attualità che noi non
cogliamo più erano ben chiari per i
lettori che affollavano le vie di Roma, ridendo
e dandosi di gomito per la vittima del giorno;
oggi quei versi hanno un respiro diverso,
parlano di cinismi e ipocrisie che non hanno
tempo.
- Proprio la sua attenzione per la cronaca,
il suo "cavalcare" la cronaca, sembrarono creare
un contrasto piuttosto vistoso con la quasi
totale assenza di poesie ispirate ai fatti della
prima e, più tardi, della seconda guerra
mondiale. Ciò che, del resto, gli fu
rimproverato da molti critici. In realtà
qualche poesia c'è, come Il Natale di
guerra o La ninna-nanna de la guerra che, a
riprova del cordone ombelicale che lega Trilussa
ai romani, molti anni dopo sarebbe stata
musicata da Claudio Baglioni. Leggere ora quelle
poesie vuol dire provare un brivido di
commozione; vien da pensare, oggi, che
l'atteggiamento di Trilussa di fronte allo
strazio dei bombardamenti e dei massacri ("Sur
vecchio campanile der convento / nun c'è
la rondinella pellegrina / che canta la canzone
der momento: / però, in compenso, romba e
s'avvicina / un trimotore da bombardamento"
presagiva nel 1938) non fosse dettato da facile
scetticismo piccolo borghese, da un generico ed
epidermico orrore del macello, ma da una
disperazione più larga e da una
compassione eterna per il piccolo, meschino
essere che è l'uomo. Da una malinconia,
da un'infinita tristezza per la giustizia e la
verità che non ci sono e non ci saranno
mai senza che gli uomini cessino ugualmente di
immaginarle, di sognarle, di sentirsi pronti per
dare loro consistenza in terra. Da questi
sentimenti nasceva il Trilussa lirico, quello
che confessava quasi sottovoce di conservare
gelosamente sul comodino i Canti di Leopardi;
nascevano quegli scorci gentili fatti di
diminutivi e di esili figurette, quei versi
sospesi insieme alla biancheria splendente al
sole o arrossati di tramonto; quelle rapide
aperture a un sé sempre mascherato (non
dimentichiamo La maschera) che fa capolino in
una sera d'estate; quei malinconici parchi e
scialletti consunti stretti intorno a spalle
magre; tutte immagini che sono come un piacere
de senti' dolore nella favola che tutti
conosciamo: "Pe' conto mio la favola più
corta / è quella che se chiama
Gioventù: / perché c'era una vorta
/ e adesso non c'è più. / E la
più lunga? è quella de la Vita: /
la sento raccontà da che sto ar monno, /
e un giorno, forse, cascherò dar sonno /
prima che sia finita".
-
- Olivia Trioschi
-
|


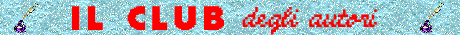
ins 26 giugno 2000